Alcuni antefatti
|
Alla
vigilia della seconda guerra d’indipendenza, il Lombardo-Veneto,
sotto amministrazione austriaca,
comprendeva 17
province, suddivise in distretti e comuni. Le province lombarde erano
nove, quelle venete otto. Alla sconfitta dell’Austria conseguì
l’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna, ma non quella del
Veneto che, con l’armistizio di Villafranca (11 luglio 1859) in
dispregio degli accordi di Plombières, restò sotto gli
Asburgo. Le province venete furono annesse, praticamente inalterate,
solo nel 1866.
 In vista dell’annessione al Regno di Sardegna, con un decreto del 27 dicembre 1859, il “dittatore” dell'Emilia e delle Romagne Luigi Carlo Farini riorganizzò i territori già sotto i ducati di Parma e di Modena (compresa Massa) e in parte sotto lo Stato Pontificio, in nove province. Esse furono strutturate in circondari, mandamenti e comuni, in conformità con quanto era stato stabilito dalla legge Rattazzi. Tale assetto fu confermato con l’Unità d’Italia.  Nel 1850 lo Stato Pontificio, in applicazione dell’editto di Pio IX del 22 novembre, fu riordinato in cinque regioni, dette legazioni (Romagna, Marche, Umbria, Campania e Marittima, Roma) a loro volta suddivise in 20 province (dette delegazioni), formate da distretti. Con l’Unità d’Italia tale struttura amministrativa subì diversi cambiamenti – molte province furono accorpate e in parte ridisegnate – tuttavia spesso i nuovi confini corrisposero a quelli precedentemente segnati. Il decreto Minghetti del 22 dicembre 1860 coinvolse in particolare il riordinamento di Marche e Umbria. Roma, con la sua provincia, si aggiunse solo nel 1870.  |
Con legge del 23 ottobre
1859 (nota come “decreto Rattazzi”) fu
ridisegnato l’assetto amministrativo del Regno di Sardegna,
compreso
quello della Lombardia in vista della ratifica dell’armistizio di
Villafranca. Il
territorio risultò diviso in 17 province, suddivise in
circondari, mandamenti, e comuni. Le province lombarde furono
confermate tranne quelle di Lodi-Crema, spartita tra Milano e Cremona,
e di Mantova, gran parte del cui territorio era restato
all’Austria
trovandosi oltre la linea d’armistizio. Fu inoltre ridisegnata la
provincia di Pavia. L’assetto del decreto Rattazzi transitò nel
Regno d’Italia, ma senza le province della Savoia, Ciamberì e
Annecy, e di gran parte di quella di Nizza (i cui resti costituirono la
provincia di Porto Maurizio), cedute alla Francia per via degli accordi
di Plombières.
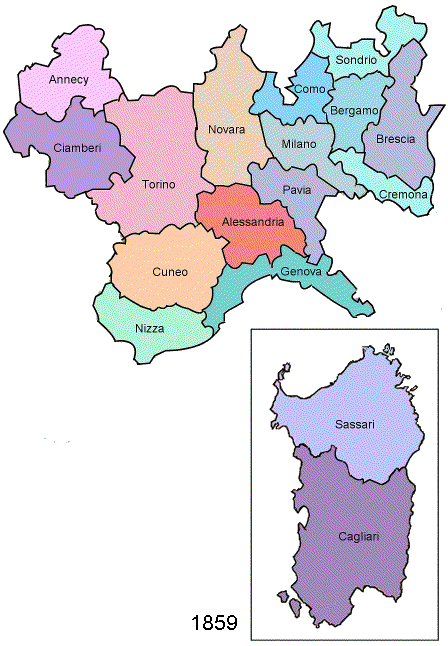 Intorno al 1850, dopo l’acquisizione della repubblica di Lucca (1847), il Granducato di Toscana era ripartito in sette compartimenti, suddivisi in distretti e comunità (Livorno e l'isola d'Elba avavano uno status particolare). I compartimenti furono quasi del tutto confermati con l’Unità d’Italia: diventarono province, con l’eccezione di quello di Pistoia che fu abolito e spartito tra le province di Firenze e Lucca. In generale tuttavia, le province toscane raggiunsero un assetto stabile solo nel 1865.  |
 |
La suddivisione
amministrativa
preunitaria del Regno delle Due Sicilie a livello provinciale
passò quasi inalterata nel Regno d’Italia. Le province erano 22,
formate da distretti, circondari e comuni. Per quanto riguarda le
province “al di qua del faro”, vale a dire le 15 del Regno di Napoli,
che risalivano al XV secolo, esse mutarono di nome, ma mantennero quasi
tutti i confini e anche l’araldica. Le sette province “al di là
del faro”, cioè della Sicilia, che invece furono istituite nel
1825,
passarono tali e quali al Regno d’Italia.
Gli antefatti qui riportati considerano la geografia delle provincie, non la loro struttura amministrativa interna, diversa per i vari Stati preunitari. Per armonizzare quest’ultima occorsero vari anni. |


